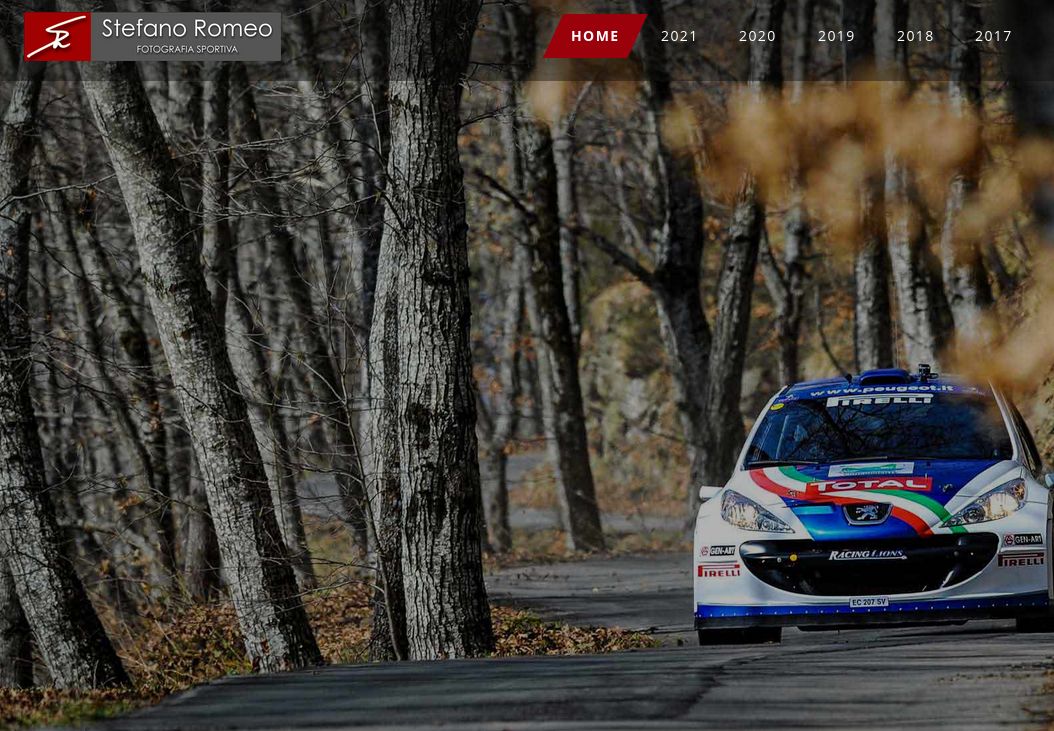CAPITOLO X
Bergamino guarda sua moglie, sa che Cecilia è dalla sua parte, anche se le racconta un fatto come lo scandalo del convento di clausura. Che sia vero o immaginato, non ha importanza, per lei è senz’altro accaduto, tanto che se lo ricorda, lo arricchisce e gli fa sapere quanto una piccola storia sia radicata nella grande Storia. Se poi il prete infoiato abbia generato tutti quei poveri bimbi, e abbia sfidato i Provveditori per gettarli nel Ticino, e se anche il boia maldestro esiste solo nel suo sogno, nel tempo del loro discorso e nel tempo della fabula non è detto che tutto debba coincidere, non c’è un intreccio come in una storia cantata in cui la musica accompagna il racconto.
Una storia, che essa sia scritta o narrata, stimola in ogni caso l’interesse dell’ascoltatore o del lettore, nel tempo che l’ascolta o nel tempo che la legge, mentre un’opera visiva, una grande piramide per esempio, richiede un tempo diverso di osservazione, per la complessità della sua struttura. Anzi, sta lì, non ha nulla da spartire col tempo, tranne mostrarci il suo di tempo, percorso negli anni, raccontandoci così la sua storia.
“Quando scrivo una storia” spiega Bergamino a Cecilia, “a volte la racconto in poche parole, in altre mi perdo in descrizioni, o in quisquilie di particolari che altro scopo non hanno se non quello di abbreviare o di prolungare il tempo della lettura. Ti dirò, non sempre lo faccio con intenzione, posso anche non accorgermene. Il più delle volte avviene non perché io penso al lettore, ma perché diverte me stesso, mi fa star bene, e allora prolungo il mio godimento, altrimenti taglio, non mi attardo in minuzie inutili.”
“Mi piace ciò che mi dici! E’ come se a volte tu fossi allucinato da quello che scrivi, altre disturbato…”
“Può darsi Cecilia che sia così. Nel sogno la scena del boia incapace non finiva più, una scena macabra e terribile fin nei minimi particolari, non potevo guardarla, ed è probabile che mi sia svegliato per fermare quel maledetto! Ti dirò che non sono per nulla sicuro che avesse usato il coltello per completare l’opera, anzi sono certo che l’ho inventato io, per abbreviare, per tagliare, anche se, non volendolo, ho reso la decapitazione ancora più lugubre.”
“Sì, quel coltello mi ha disturbato molto, un vero particolare agghiacciante. Forse il boia del sogno era un uomo colto, non sapeva maneggiare l’ascia, o forse era un ammiratore di Aristotele che sosteneva che la catastrofe e la catarsi di un’azione tragica dovessero essere preannunciate da terribili traversie e impensabili calamità a non finire.”
“Mi fai sorgere un sospetto: non ti sei accorta che stiamo filosofando, da non so quanto tempo, su argomenti cervellotici scatenati da un mio sogno? In altre parole stiamo indugiando senza dir nulla che possa allargare il nostro discorso che sta lì, campato in aria. Continuiamo a navigare tra i marosi, senza concludere. La domanda che mi pongo è questa: perché sono andato a Cremona a curiosare nell’Isola dei Monasteri? Tra i motivi narrativi del mio sogno, ce ne sono parecchi, se sbagli puoi pagarla cara, oppure, se non sai fare il tuo mestiere non insistere, e via dicendo, ma quello che mi sembra più importante è che, se metti al mondo dei bimbi, non li vai poi a buttar nel fiume. Ho l’impressione che nel nostro ducato si procrei veramente un po’ troppo.”
“Non solo nel ducato di Milano, direi in tutta Italia, anche in Europa!”
“Rimaniamo in casa nostra, non vorrei mettere il dito nella piaga, cominciamo dal Moro. Ammetti che di figli, dentro e fuori dal cavagnolo, ne ha prodotti finanche troppi, senza poi annegarli. Il malumore in casa Sforza è dovuto alla contemporanea attesa di due gravidanze, quella di Beatrice e quella di Lucrezia.”
“Purtroppo è così che va il mondo, me ne dispiace moltissimo, Beatrice ha tutte le ragioni.”
“Il guaio è che in molti casi finzione e realtà sembrano mescolarsi, e noi leggiamo una realtà come se fosse finzione e la finzione come se fosse realtà.”
“Che cosa vorresti dire, esattamente…”
“Che alcune volte tale mescolanza può risultare anche piacevole e innocente, altre necessarie, altre drammaticamente allarmanti. Se scrivessi, per esempio, una lettera in cui parlo di queste due gravidanze, e la facessi recapitare al duca di Ferrara, arricchendola di mille particolari perfettamente corrispondenti al luogo, alle persone che lo abitano, e al seminatore, e non firmassi la missiva, che cosa ne penserebbe il padre di Beatrice? In ogni caso farebbe un salto, sia che lo sapesse o no. Non avrebbe importanza il vero o il falso. Si metterebbe subito in uno stato di allarme. Conoscendo le abitudini del Moro, non starebbe a ragionare se la notizia è vera o falsa, si domanderebbe, se mai, perché gli è arrivata tramite una lettera anonima. Sicuramente farebbe delle indagini, convocherebbe Giacomo Trotti, il suo fidato diplomatico perché si informi, con cautela, se quella missiva descrive un universo reale o un mondo immaginario. Sarà un’impresa difficile, perché la scriverei con molta attenzione, magari con richiami a fatti conosciuti, usando parole ricercate e pretenziose, da persona colta, come fa il Boccaccio nelle sue novelle, o addirittura Dante nella Commedia. Insomma, userei uno stile che farebbe sorgere il dubbio di una finzione narrativa che fa finta di dire la verità, oppure si assume di dire la verità nell’ambito di un universo finzionale. Capisci Cecilia perché mi diverto a creare delle storie, magari attingendo alla realtà?”
“Capisco, così è più chiaro, e aggiungerei che la finzione appare ancora più vicina alla realtà se si insiste su dettagli storicamente inverificabili.”
“Non solo, spesso io mi ci trovo dentro, non perché ho deciso di entrare in una situazione immaginaria quando scrivo. A un certo punto mi accorgo che quello che mi succede è simile a un sogno e, se non sto attento, ho dei problemi, sia che scriva o legga qualcosa che mi avvince.”
“Succede anche a me quando leggo qualcosa che mi attrae, mi immedesimo a ciò che accade, prendo sul serio il personaggio fittizio. Sapessi quante volte ho riletto il canto ventiseiesimo dell’Inferno, al punto che lo so a memoria. Il canto di Ulisse! Io sono lì che ascolto “Lo maggior corno de la fiamma antica”, la vedo muoversi e la sento raccontarmi il suo ultimo viaggio. Sono immersa in una realtà vera!”
“La metafora della fiamma biforcuta, la lingua di Ulisse e Diomede, produce al tempo stesso una immagine reale, la fiamma, e una fittizia, la lingua che parla e pure tu abiti contemporaneamente due universi, il visivo fittizio della fiamma che tremola e l’uditivo reale acustico delle parole che leggi e ascolti mentre le reciti a memoria.”
“Verissimo, però tu non scrivere quella lettera per Ercole d’Este!”
CAPITOLO XI
Cecilia Gallerani lascia il Moro dopo la nascita di Cesare, il figlio da lui avuto, e sposa il conte Carminati di Brembilla, come sappiamo. E’ vero che perde i benefici di vivere nel Castello Sforzesco di Milano e di seguire il duca ovunque vada, però, tranne un breve periodo iniziale in cui è inseguita ancora dall’amante, trova nel marito l’unico con cui si senta appagata. La sua vita è di gran lunga più tranquilla, e può nella Villa Medici del Vascello tenere numerosi incontri con artisti, poeti e letterati. Trasforma il castello del marito in un luogo ospitale, aperto a personalità di alta levatura culturale. Crescendo, raggiunge una sorta di nirvana borghese, facendo del consorte, dopo un periodo di infelicità, un compagno. Stanchi dei litigi e delle provocazioni, si sentono sicuri l’uno con l’altro, salgono in camera senza fretta e si abbandonano a lunghi preliminari. Concludono addormentandosi e tenendosi per mano. Nei precedenti rapporti Cecilia, intimidita dalla bellezza del suo corpo, era incapace di trarne quel piacere definito, con insufficiente fantasia, fisico, ma ora il suo erotismo si trasforma in una apoteosi tra estraniazione e immedesimazione. La stessa percezione, un po’ meno vistosa, si verifica in Bergamino che di fronte a tanta avvenenza si dimentica della sua senilità. Da siffatta frenesia amatoria nascono ben quattro pargoletti. Si potrebbe pensare che questa ripetizione del giri e rigiri nel letto, da parte dei due amanti, prima di prendere sonno, sia quasi ossessiva, e in parte lo è, in chiave scaramantica, per allontanare finché è possibile, la paura della morte. Molte altre azioni si fanno, nolenti o volenti, con lo stesso scopo, perché nutrirsi, camminare o correre, parlare o scrivere significano in fondo vivere, e sono più appetibili se si coniugano con la bellezza, la bontà del cibo, il passeggiare in un bosco, e via dicendo. Sovente l’indugio prepara la sorpresa dell’azione che segue, ma l’attesa di Beatrice d’Este questa volta è tutt’altro che piacevole. Due figli maschi ha partorito prima di quest’ultima gravidanza, Ercole Massimiliano e, due anni dopo, Francesco. La consapevolezza che la sua nuova gestazione procede di pari passo con quella di Lucrezia Crivelli la tormenta senza darle respiro. E’ depressa ogni giorno di più, non le importa di vivere o di morire, l’affronto subito in casa sua è troppo forte, non può sopportarlo. E’ infelice perché il tradimento di suo marito è noto a tutti e le giungono alle orecchie le chiacchiere di palazzo, l’ironia che le accompagnano, un controcanto sempre presente a ciò che si mormora. Non giudica quel che ipocriti servili si dicono, lo fa proprio. Ne soppesa l’aspetto doloroso al quale non fa difetto l’aspetto comico, molto più penoso. Si chiude nel silenzio inespressivo, si turba davanti a termini per lei inaccettabili quando pensa o si parla di Lucrezia, sua dama di compagnia? amica? compagna? Solamente una volgare cortigiana, titolo molto improprio, protettivo, che la salva da quell’altra ben nota terminologia della più antica professione del mondo. Ludovico il Moro se si guardasse spesso allo specchio, si vedrebbe com’è realmente, un seduttore sedotto, un uomo portatile, a letto. Va da sé che la gravidanza prosegue, ma non promette nulla di buono. La pratica ostetrica nel XV secolo è ancora prevalentemente chirurgica. Ambroise Paré, medico e chirurgo francese, considerato il padre della chirurgia moderna, chirurgo regale del re di Francia Enrico II e della regina Caterina de' Medici, al quale va il merito di aver introdotto la legatura dei vasi in seguito alle amputazioni, e di aver applicato per primo in ostetricia il rivolgimento podalico nel parto difficile, avrebbe esercitato mezzo secolo dopo. Il parto avviene nella notte fra il 2 e il 3 gennaio 1497, ma né la madre né il figlio sopravvivono. Ludovico impazzisce dal dolore; per due settimane rimane rinchiuso al buio nei propri appartamenti, dopodiché si rasa il capo e si lascia crescere la barba, e da quel momento in poi indossa solamente abiti neri con un mantello da mendicante. Unica preoccupazione diventa l'abbellimento del mausoleo di famiglia. Lo stato, trascurato, va in rovina.
Come finisce il Moro è noto, lo conferma la Storia. Però il Bergamino avverte di quanto il romanzo, riconosciuto come “fratello carnale della Storia”, si mescoli con la vita e la vita con il romanzo. Rimangono, ovvio, degli spazi vuoti nell’intreccio, e sta a chi legge, dice sempre il Bergamino, riempirli, perché in ogni finzione narrativa non è possibile dire tutto. “Se io scrivo che prenderò la strada - spiega sempre il conte – e che arriverò a notte tarda, è sottinteso che prenderò la carrozza, oltre alla strada. Per dire troppo arrischierei di diventare più comico dei miei personaggi! Immaginate se io aggiungessi che la cartomante mi ha assicurato che la giornata sarà splendida, anche se freddissima, e di non preoccuparmi se farà buio presto, la luna illuminerà la strada come di giorno.”
Il Bergamino segue da lontano la fine del Moro. Carlo VIII reduce dalla marcia fallimentare di andata e ritorno a Napoli, è tutto preso dai preparativi per una nuova spedizione, quando il 7 aprile 1498, per aver violentemente dato del capo in una porta bassa, muore dopo nove ore di agonia. Gli succede Luigi XII che occupa il ducato di Milano costringendo il Moro a rifugiarsi presso l'imperatore Massimiliano I d’Asburgo a Innsbruck. Il Duca tenta di riconquistare Milano, ma viene tradito dai suoi mercenari svizzeri e cade prigioniero dei francesi. Morirà nel Castello di Loches il 1508, assistito dai conforti religiosi.
L’attenzione di Bergamino, più che dalle vicende ultime del Moro, è attratta dai mercenari svizzeri. A parte il fatto che vengono arruolati da molti stati, sia per la loro bravura in combattimento, sia per le loro tattiche innovative e per il coraggio e la ferocia che li distingue, d’altro canto spaventano non poco per la diffusione del mal francese e per le mire espansionistiche. Da tempo vantano diritti sulla lingua di terra italiana che si insinua, a Nord, nel Vallese e nel Ticino, l’Ossola, terra frequentata dal conte Carminati da molti anni, la Val Vigezzo in particolare, nella stagione dei funghi e della caccia. Possiede persino una baita in montagna, per questo scopo. Nel 1487, il Bergamino, ancora scapolo, decide di allontanarsi da Milano e di trascorrere in pace un po’ di tempo nell’adorata valle. Vuole stare un po’ lontano da congiure, torture e decapitazioni, fustigazioni, numerosi avvelenamenti sempre con esito in “morte naturale”, per non parlare di squartamenti con successiva esposizione dei pezzi appesi alle porte del castello. Sceglie male il periodo. Esiste infatti una grossa rivalità fra il Vallese e l’Ossola per dispute territoriali e religiose. Gli svizzeri, al comando di Jost von Silenen vescovo di Sion, invadono nel 1484, tre anni prima, la Val d’Ossola, saccheggiandola sino a Domodossola. In seguito a questa offensiva, gli altri cantoni svizzeri lo condannano al pagamento di una somma di denaro, dal momento che i novaresi lo accusano di essersi spinto a rapinare arredi sacri dalle chiese ossolane. Il vescovo vallese si vendica. Nello stesso mese e anno in cui il Bergamino si gode la sua baita, aprile 1487, Jost von Silenen invade ancora una volta la Val d'Ossola con un esercito di 4 500-5 000 uomini e assedia il castello che si trova sul colle Mattarella a protezione della città. La guarnigione riesce a contenere il nemico ed inviare una richiesta d'aiuto a Milano. E’ un freddo mattino, fa ancora buio. Dei colpi d’archibugio, in un rapido susseguirsi, ingigantiti dagli echi dei monti fa sobbalzare il Bergamino e i quattro suoi amici che dividono con lui la piccola baita.
Si trovano in cima ad un alpeggio, la Colma, a 1600 metri, ancora ricoperta di neve. Si coprono ed escono. Fa freddo, soffia un vento gelido che trasporta fin lassù uno scampanio continuo dal fondovalle. Bagliori di incendi si scorgono tra le case dei piccoli paesi.
“Un’altra volta gli Svizzeri” urla il Bergamino, “scendiamo, dobbiamo salvare i cavalli!”
Armati di balestre, si precipitano a valle, scivolano, si rialzano, raggiungono il primo paese, Craveggia. Ritrovano i cavalli nella stalla dove li hanno lasciati, il paese è intatto. Gli svizzeri sono la retroguardia di un piccolo esercito che attraversa la Val Vigezzo. Saccheggiano, distruggono, incendiano. Vogliono raggiungere i confederati nella piana di Domodossola e gli ultimi carri sono ormai dove la valle si restringe dopo Druogno. Non è la prima volta che gli svizzeri tentano di conquistare questa terra di grande importanza strategica, fin dal Medioevo. Il Moro invia in soccorso un esercito di fanti, cavalieri e balestrieri a cavallo al comando di Renato Trivulzio. L'esercito sforzesco riesce a sconfiggere i presidi lasciati dagli svizzeri a difesa dei guadi sul fiume Toce, costringe il nemico a ritirarsi verso Crevola. Nel frattempo i milanesi informati del fatto che un contingente di circa 1 000 svizzeri, depredata la Valle Vigezzo, cerca di riunirsi al grosso dell'esercito, inviano i cavalleggeri e i balestrieri a cavallo al fine di rallentarli in attesa dell'arrivo della fanteria. Gli svizzeri assumono la tipica formazione difensiva a quadrato ma, tormentati dai balestrieri milanesi, ai quali si unisce il gruppo del Begamino, rompono le righe e cercano di inseguirli. Quando la fanteria milanese giunge sul posto li circonda. Gli svizzeri, non più in formazione, sono annientati. Sorte peggiore hanno i superstiti fatti a pezzi dai valligiani o morti di fame dispersi tra i monti. Gli sforzeschi assaltano il ponte di Crevola, dove gli svizzeri oppongono una strenua resistenza finché i cavalleggeri milanesi, una volta guadato il fiume più a monte, li sorprendono alle spalle costringendoli alla fuga. Al termine della battaglia gli svizzeri, tra morti e feriti, perdono un terzo delle loro forze. Crevola è la peggiore, nonché l'unica, sconfitta subita dagli svizzeri dalla nascita della Vecchia Confederazione che, Il 23 luglio 1487, stipula un nuovo trattato di pace con il Ducato di Milano.
CONCLUSIONE
Alla notizia della morte del Moro, il Bergamino rilegge la descrizione della battaglia di Crevola da lui vissuta, scritta e dimenticata nel ripostiglio della libreria per più di vent’anni. Conclude che tranne quel successo, gli svizzeri hanno sempre portato iella al duca. Verso la fine di marzo del 1500, un'armata francese guidata dal re Luigi XII di Francia muove sul Ducato di Milano, difeso da Ludovico il Moro: le due armate si fronteggiano davanti a Novara ma i mercenari svizzeri di Ludovico si rifiutano di affrontare i loro compatrioti che militano nelle file francesi e alle truppe milanesi non resta altro che trincerarsi nella città, tagliate fuori e assediate dall'armata di Luigi. La Dieta svizzera negozia un compromesso in modo da evitare una battaglia tra svizzeri, "fratelli contro fratelli e padri contro figli". Luigi accetta di garantire un libero passaggio ai mercenari svizzeri a condizione della resa dello Sforza. Gli svizzeri assoldati da Ludovico cercano di farlo uscire dalla città travestendolo da mercenario ma al suo passaggio attraverso il controllo francese, Hans Turman del cantone di Uri, indica lo Sforza che viene arrestato e incarcerato nel castello di Loches. Turman viene ricompensato con 200 corone d'oro e fugge in Francia. Dopo qualche anno ritorna nel cantone di Uri ma viene arrestato per tradimento e decapitato.
Il Bergamino aggiunge queste considerazioni alla storia di Ludovico il Moro e dà l’opera alla stampa, ma non riscuote successo. Ne fa allora una seconda edizione alla quale aggiunge qualche modifica ma, soprattutto, una frase fatidica, scritta in latino per fare più impressione: Legit illud sicut-historia liber novis. Tradotto significa, si legge come un romanzo, sapendo che molte pagine sono solo lontane verosimiglianze. Un allettamento pieno di pericoli e di rischi, qualora il Moro fosse ancora vivo, ma tant’è, “Audentes Fortuna iuvat” è l’esortazione rivolta ai suoi uomini ad attaccare Enea che Virgilio mette in bocca a Turno nell’Eneide. Bergamino osa, scrive con un sorriso sornione, con l’alibi di uno pseudo colto molto riconosciuto, un disidentico ben noto, un nobile, un guerriero, un cortigiano, un consigliere, e soprattutto il marito della più nota e bella amante del Moro. Apprezzato maestro nell’uso delle bombarde di cui apprezza non tanto i suoni, quanto gli echi dei loro suoni, non si trova come Dante nella selva oscura, perché non si perde nell’inventarsi, ha tutto sotto controllo, e l’immaginazione non si dissocia dalla realtà di molto, lascia magari perdere la pignoleria della Storia, la sua noiosità di date, nomi, genealogie e, se mai, orienta il lettore non su cosa sa già bensì, come l’ago di una bussola, l’orienta per non perdersi a far la fine del sommo poeta. La Storia, vista dallo storico, lo possiede come Cecilia o Lucrezia possiedono il Moro e, come tutte le amanti tradisce alla fine chi le insegue. Per sua fortuna il tradito storico non lo saprà finché vive, la conferma arriverà, quasi sempre, dopo la sua morte. Il Bergamino sa bene di non offrire un romanzo dove lui ricorda tutto, non è un genio, è solo un narratore al quale basta il talento. Uno dei privilegi dello scrittore è quello di conoscere la vita nascosta dei suoi personaggi. Lo storico non potrà mai fare altrettanto, la vita nascosta lo è per definizione. Ed ecco ricomparire l’ossimoro: il Bergamino al quale si chiede come dovrebbe essere il personaggio Maestro nell’uso delle bombarde che lui descrive, sorride bonario e schietto risponde: “esatto e immaginoso”, poi corrugando la fronte, sussurra: “Io invento con verità!”