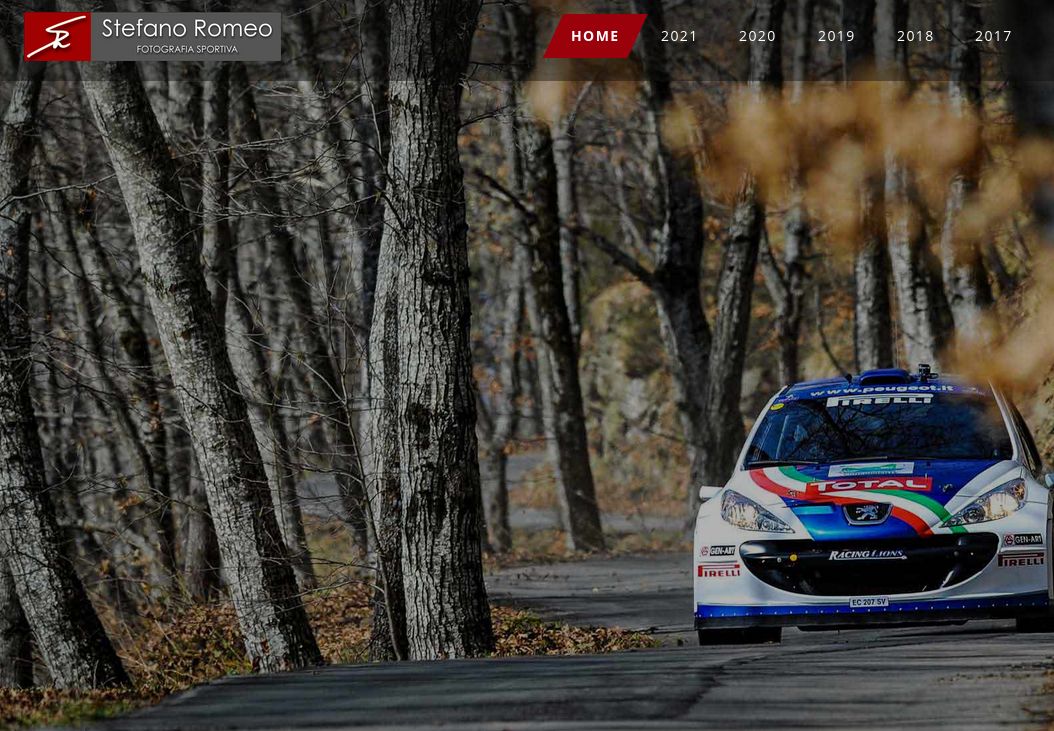“Mi guardo allo specchio, borbotto, come ho potuto essere così stupido? E sì che ne ho avuto di tempo per riflettere! Bello avere sospetti di un rivale che da alle disavventure, ai guai, il capo di filo per risalire all’origine di uno sbaglio commesso, di un errore dimenticato. Allora anche la disdetta è utile e se ne può trarre un senso... Il fatto che qualcuno incontri mia moglie, come tutti sanno, mentre io faccio finta di non sapere, mi costringe a ragionare sulla stupidità. Mi accorgo, però, di quanto sia complessa la mente. La mia mente! Devo cercare di costituire almeno un nucleo attorno al quale possa raggruppare il risultato delle mie ricerche, dei miei sentimenti sempre più confusi. Mi rendo conto di non avere un’opinione dominante e, forse, è un bene. Mi si impone, pertanto, di aprire con me stesso il privato, anche se, al solo pensiero, provo imbarazzo e nausea. Non manco, del resto, di intelligenza e di spirito, ma non è come se mi trovassi in una sala nobile, obbligato ad aprirmi a un pubblico goloso di pettegolezzi avvelenati.”
Il conte Ludovico Carminati di Brembilla, detto il Bergamino, distoglie lo sguardo dallo specchio, il suo pensiero abborda la questione dell’età sulla terra che continua la sua marcia, sempre più cambiando in nuove scoperte che distruggono non solo le vecchie. Si domanda perché mai ci siamo evoluti. Pensa alle scimmie: mangiano, si rilassano, giocano, dormono, non fanno nulla e si accoppiano come forsennate.
“Cecilia, come può continuare a farmi questo affronto?” continua a rimuginare farfugliando a bassa voce. “Se ne va dove vuole, e ha pure l’impudenza di dirmelo. Nessuna spiegazione. Poche parole, come se non fosse una nota artista esoterica, fondatrice della Scuola degli Occulti, e non una donna priva di vocazioni, senza genio, con un talento apparente, senz’anima creativa. - Vado a far due passi - mi dice. Una povertà di espressione che non ha quando dipinge oscuri paesaggi, figure mitologiche ed unicorni, nature morte che sembrano vive, che solo iconoclasti in crisi di astinenza possono comprare.”
Il matrimonio è idilliaco all’inizio, ricco di note esaltanti e di sessualità passionale dalle molteplici sfaccettature. Il conte la sposa su sollecitazione di Ludovico Sforza, il Moro. Cecilia è oltremodo attraente, ha solo diciannove anni. A lui poco importa che sia stata per tre anni l’amante del Duca di Milano, non gli par vero di avere per consorte una splendida giovane, sicuramente esperta di raffinate arti amatorie. Poi, però, la realtà di essere sposata a un uomo
di parecchi anni più vecchio, si fa avanti in Cecilia. E sì che Isabella, la sua più cara amica, l’ha avvertita di non prendersi un marito di età così avanzata, la cui carica erotica col tempo diventa problematica, si spoglia delle fantasie, i rapporti si fanno sempre più rari. Ha bisogno di riposo,
il suo corpo non nasconde i segni dell’età, i suoi capelli radi e grigi, malgrado l’unguento al midollo di bue che usa ogni giorno, raggiungono l’inevitabile calvizie. Soffre alle ginocchia, gonfie per l’artrosi, vende la casa nel parco dove amava cacciare, senza consultarsi con Cecilia. La frustrazione lo trasforma, teme che gli venga il mal caduco. Sintomi comportamentali anomali si aggiungono, non riesce ad evitarli. I suoi atteggiamenti sono difensivi, risponde a Cecilia
come se il futuro non esistesse, come se fosse irrilevante e sconfina nel passato, tirando in ballo vecchie storie di gioventù. A volte aggressivo, scorretto, cattivo, l’accusa di atteggiamenti materni inopportuni. Alla fine i diverbi sembrano fargli raggiungere un porto più sicuro, ma l’abbandona presto, riprende la navigazione in un mare in tempesta, e non naufraga mai. Brandelli di accuse artificiose ritornano a sfocare gli scambi verbali.
Quando rientra, sorseggia alcuni bicchieri di zithus, una birra altamente saporita, si siede al suo scrittoio fratino, e scrive del tempo che fu. Ne pettina i tormenti, le infinite malinconie. Ne nasce così un libro, poco alla volta, grazie anche alla stampa che si avvale di un nuovo materiale scrittorio di poco prezzo, la carta e, con essa, di uno stampatore.
“Trasporto i miei pensieri su supporto cartaceo” spiega agli amici, “ dopo sto meglio, mi è terapeutico e, in più, rimane qualcosa di me stesso.”
Il Rinascimento sta per arrivare ed è all’inizio del suo faticoso percorso, anche a Milano. Gli editori aprono la strada a un genere sapienziale che solo pochi possono leggere. Le opere
si divulgano soprattutto in alto loco, come il Proverbiorum libellus. La stampa con i caratteri mobili, esiste ormai da cinquant’anni e subisce una rapida evoluzione dedicandosi a un lontano passato, poi, con crescente curiosità, al mondo circostante, alle nuove leggi, alle invenzioni e al tempo di cui dispone l’effimera esistenza umana. I rapporti intermittenti del Bergamino con il prossimo diventano sempre più rari. Non può abolire le noiosissime feste, manifestazioni che ritiene tristi, dolorose, ripetitive, troppo spesso subite più che vissute. Dell’attività di cortigiano del duca, non scrive, tutt’al più ne parla. La sua scrittura è ironica, a volte sarcastica. Persino
la chiesa è soltanto una sala riunioni qualsiasi, l’arciprete un laico circondato da belle donne e ballerine. Alla danza, tenuta in grande considerazione alla corte ducale, vi partecipano anche alti prelati. La sua scrittura denuda la vecchia e la nuova società. La maggior parte del tempo la trascorre allo scrittoio, trasforma i ricordi in racconti che fanno ridere. Alcuni li fa stampare e li regala agli amici. Si sente strano, come se fosse in bilico tra un bisogno di star fermo e,
nello stesso tempo, una gran voglia di muoversi, di correre via. Non s’arrende, resiste, per metà depresso, per metà gaudente. Scrittura e verbosità differiscono, quasi un ossimoro. Ciò che nella vita lo demoralizza e l’affligge, nello scritto rinasce e lo rallegra. Come un sanculotto ante litteram ammassa i parenti dei sospetti o le persone sospettate di essere amiche dei sospetti, e pure lui immagina la sua ghigliottina. Scrivendo, si trasforma, diventa un poeta, gioca con le parole che a volte uccidono. Poi ride, per non piangere. Da uomo di spada si trasforma in un uomo di penna. Con alterne vicende, i rapporti col duca si improntano a confidenza e a diffidenza insieme, a conferma della sua dominante ambivalenza. Il Moro, sposato da poco con Beatrice d’Este, vuole allontanare Cecilia e Cesare, il pargoletto appena avuto dall’amante. Lo chiede, anzi lo ordina al Bergamino, che gli dia una mano, perché non vuole cadere in un impressionismo arbitrario, al di là di ciò che si possa pensare, e si chiacchieri di una verità che tutti sanno. Non vuole correre rischi. Come potrebbe rimediare? Ridacchia il Bergamino, e scrive uno strano dialogo che gli viene in mente.
“Beatrice, vieni a vedere, ci hanno messo nella nostra stanza un pargoletto che un po’ mi assomiglia. Solo che non si sono accorti che è falso...”
“Non capisco, come sarebbe a dire? E chi può averlo fatto?”
“Una qualche cretina in vena di corbellerie” risponde il Moro, voltandole le spalle.
“Tu dici?” replica Beatrice. Gli si avvicina furtiva da dietro, lo bacia con tenerezza sul collo e gli conficca una lama tra le scapole.
“Ahhh” fa il duca accasciandosi, con un sorriso sornione.
Il Bergamino si trattiene, non prorompe in una risata schietta solo perché stringe i denti. Straccia in minuti pezzi lo scritto. Prudenza, non si sa mai!