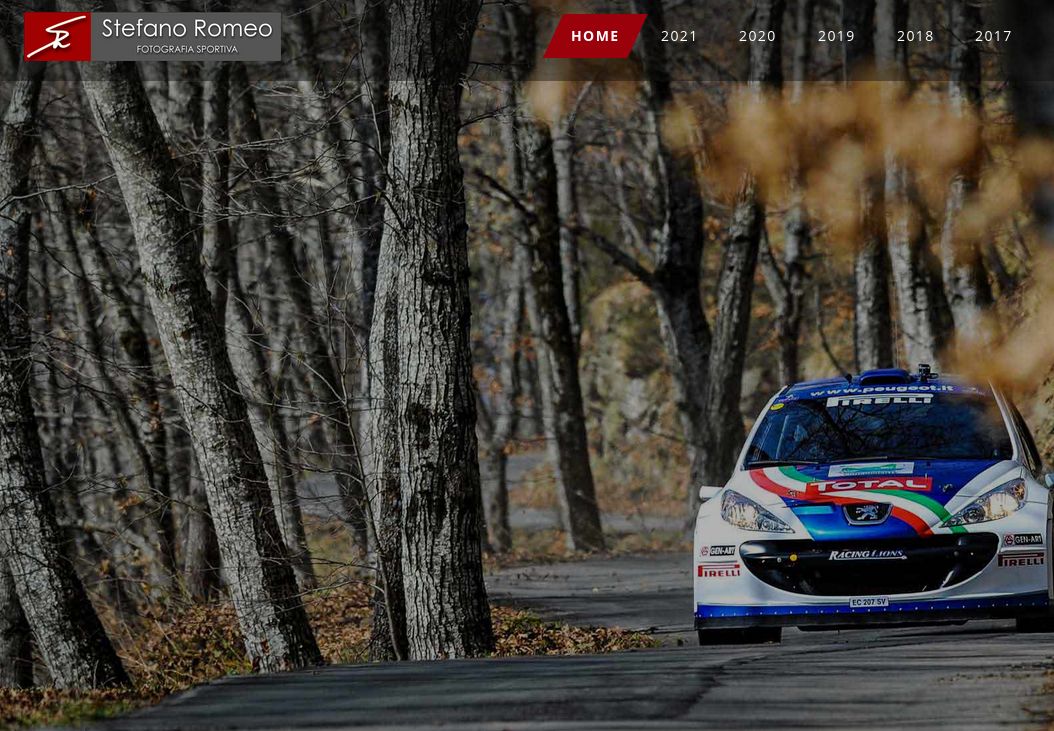Se Gian Galeazzo Maria palesa indifferenza davanti allo strapotere dell'ormai troppo ingombrante tutore, Isabella manifesta una tenace volontà nel rivendicare il proprio ruolo di duchessa ufficiale, mettendo i bastoni tra le ruote a Ludovico. Questi, dopo più di un anno di vana attesa di gravidanza dal loro matrimonio, si diverte e sbeffeggia il nipote tacciandolo di pigrizia e d’impotenza sessuale. Si crea così una forte tensione con la cugina e neosposa Beatrice d'Este, ricoperta di onori e di gloria, anche se ancora vergine. Isabella è invece costretta ad un esilio perpetuo al fianco di un marito ogni giorno più insignificante che non fa che consumarsi in stravizi, astutamente alimentati dalle casse dello zio.
Ludovico attua questa strategia nei confronti del nipote perché diventi dissoluto ed effeminato nei modi, al fine di non procreare eredi, in modo da delegittimarlo agli occhi dei sudditi e delle potenze straniere. Ciononostante, il Duca diviene inaspettatamente padre di Francesco e di due bambine, suoi figli legittimi e grattacapo non indifferente per le ambizioni del Moro in quanto potrebbero ostacolarlo nell'accedere al potere. Davanti a questa prospettiva, Ludovico reagisce. Instaura un vero esercito di spie nella corte pavese, limitandone progressivamente il numero, finché non ne rimarrà che uno soltanto, Dionisio Confalonieri, spia del Moro fidatissima. Quando il Moro e Carlo VIII raggiungono Pavia trovano il duca venticinquenne gravemente ammalato. Il re si intrattiene con Isabella d’Aragona, il duca si attarda al letto del nipote. Guarda a lungo quel corpo emaciato e pallido come il lenzuolo che lo avvolge, afflitto da dolori allo stomaco, insensibilità agli arti superiori, anemia, convulsioni, vomito, diarrea, febbre, difficoltà respiratorie, sete e crisi di pianto. Gli accosta la bocca all’orecchio e gli sussurra: “Coraggio, fatti forza, domani ritorno con il mio medico di fiducia che come ha salvato me quando ero bambino, ti tirerà fuori da queste sofferenze.” Gian Galeazzo ha quasi un sussulto, apre gli occhi e volge lo sguardo allo zio che gli sorride. “Fai presto, me ne sto andando” gli risponde sottovoce. “Grazie...” I sintomi sono presenti da quando il Duca è a Pavia, mentre scemano quando egli si reca in viaggi di guarigione. Una volta ha una recidiva della malattia sotto forma di vomito dopo l’ingestione di cibo piccante e viene trattato dai medici con una purga. Un nuovo accesso è curato, apparentemente con successo, con pillole di rabarbaro tanto che nei giorni successivi è in grado di prendere parte ad una battuta di caccia e assistere ai pranzi. Il Duca non sospetta mai che lo zio stia cercando di avvelenarlo. Riceve da lui lettere piene di affetto in quei giorni. Il sospetto di avvelenamento si rafforza quando Gian Galeazzo licenzia un servo che gli dà da bere, probabile longa manus del Moro, tant’è che ritrova una certa salute. Ma il medesimo servo ritorna al suo posto per volere dello zio del Duca. Riesce ancora a montare a cavallo ma ha difficoltà a tirare le briglie. Dopo l’ultimo peggioramento al quale il Moro assiste al suo capezzale, il mattino dopo giunge Girolamo Visconti, il medico di sua fiducia. Da quel giorno il giovane, sempre assistito dalla moglie Isabella d’Aragona, entra in agonia. Venendo da Abbiategrasso, gli fa visita anche la madre, Bona di Savoia, che si trattiene presso il castello di Pavia fino al giorno in cui ha un lieve miglioramento. Malgrado le sue condizioni, il duca continua a mangiare frutta in eccesso e bere vino di nascosto, contravvenendo alle indicazioni dei medici; richiede anche due cavalli allo zio che lo accontenta. Due giorni dopo le sue condizioni di salute peggiorano significativamente tanto da impedirgli di alzarsi dal letto; vuole comunque vedere i suoi due nuovi cavalli e i suoi levrieri, poi si confessa con il priore di Sant'Apollinare promettendo di provvedere alla dote per cento ragazze povere. Nella tarda serata vomita bile e perde conoscenza più volte. I medici che lo assistono con Girolamo Visconti informano il Moro che il nipote è in fin di vita. Muore alle 3 di notte del 21 ottobre 1494.Mentre si svolgono i funerali, Carlo VIII procede nella sua fallimentare discesa su Napoli ed inaugura le guerre d’Italia, definite orrende dal Machiavelli. Attraverso la nonna paterna, Maria d’Angiò, vanta un lontano diritto ereditario alla corona del Regno di Napoli, incoraggiato da Ludovico il Moro che non è ancora duca di Milano ma solo reggente. Lo diventerà fra poco con il benestare dei francesi. Come se fosse appena ritornato dall’eternità, il Bergamino si ritrova alle esequie di Gian Galeazzo con il suo signore e con le due donne, Beatrice e Cecilia. Certo non è cosa da poco ritrovare il filo della matassa e riprendere un discorso interrotto dagli ultimi avvenimenti. La camera accogliente accanto a quella di Ludovico e di Beatrice, è sempre lì, mai utilizzata per gli scopi per i quali è stata costruita. Medita su tutto ciò che ha conosciuto prima della calata di Carlo VIII col suo esercito di 30.000 uomini, di cui ben 3000 feroci svizzeri, pensa a Beatrice, alla comune passione per la danza, sia che ballasse religiosamente la pavana o ritmicamente la nuova sensualità della mazza rocca o del saltarello, magari con il costume di un ridicolo Eros. Anche se Beatrice mostra un’espressione adatta alla funzione funebre del momento, un minimo di correlazione spirituale deve pur esistere in lei. Non può dimenticare in così poco tempo, mentre lui lustra le nuove colubrine del Moro, i sorrisi, le strette di mano, le risatine eloquenti, gli ammiccamenti furtivi d’intesa. In quei momenti lui, ricorrendo all’allegoria meno sfacciata, non è il cavaliere che balla con la duchessa, ma il dio dell’amore che amoreggia con la dea della castità. Entrambi comunicano con un enorme dispiego di gesti, di atteggiamenti, non sicuramente di esperienze. Questo incontro non è altro che una vicenda somigliante a due assetati nel deserto che trovano un’oasi e l’acqua fresca. Improvvisamente il Bergamino, forse ispirato da lievi fenomeni di confusione nati in lui da questi ricordi d’amore, trova il pensiero risolutore e si avvicina a Cecilia. Mentre le fa sottovoce una domanda, sente che i pensieri di poc’anzi non concordano con ciò che lei gli potrà rispondere. Gli pare di vivere in un dormiveglia, quando si assiste dal di fuori a strani avvenimenti e, nello stesso tempo, se ne è al centro con un Io rarefatto. “Puoi accennarmi che cosa mai è successo?” Cecilia non risponde. E’ sorpresa di vederselo accanto, pensa che sia ancora con le colubrine e con il suo esercito. Gli fa cenno di seguirla, si allontanano dalla gente raccolta in chiesa e se ne vanno lentamente fuori dove salgono su una carrozza. C’è solo un particolare molesto nelle parole di Cecilia che inizia il racconto come se ciò che sta per dirgli sia la cosa più naturale del mondo e amore, collera, felicità e umiliazione, persino il suo tono di voce, siano tutti concetti astratti e simili, ridotti a nulla, come volte di grandi cieli vuoti. In breve tempo il Bergamino vede sorgere, in rapida connessione, i colori che realizzano un nuovo quadro. Beatrice ha partorito un maschio, Gian Galeazzo è morto non si sa se avvelenato dallo zio o distrutto dagli stravizi, il Duca non si dedica più a Cecilia perché, durante la gravidanza della moglie, negli ultimi mesi i rapporti fra i due sposi si sono logorati per una nuova relazione adulterina con Lucrezia Crivelli, dama di compagnia di Beatrice. Ciononostante Ludovico é sinceramente innamorato della moglie, ma continua ad avere amanti, come del resto la maggior parte dei signori dell'epoca. Con tutto ciò, In una lettera scrive di lei: "essa mi è più cara che il lume del sole". L'affiatamento della coppia lo conferma anche Giacomo Trotti. Il Bergamino, dopo queste delucidazioni, si pone un interrogativo: come mai non ci ha pensato prima? Conoscendo il Moro, era prevedibile che tutto ciò sarebbe potuto capitare! Come ha potuto ignorarlo fino al momento che è successo? Ed ora come può fare per neutralizzarlo? Il tempo stringe e per ora il suo signore è troppo occupato con tutte quelle amanti che gli gironzolano intorno, senza tener conto della nuova amichetta a portata di mano, la dama di compagnia della duchessa. C’è poi la guerra in Italia a distrarlo, con tutti i problemi che si porta dietro il re Carlo VIII, ora sulla via del ritorno, con gli armigeri svizzeri che seminano terrore, uccidono prigionieri, violentato donne, rubano, incendiano e distruggono, lasciando alle spalle un terribile morbo, il mal francese, ribattezzato napoletano da quando l’esercitoha lasciato quella città. Cecilia suggerisce di non pensarci, di assimilare il Moro, anziché riconoscerlo, sicché l’estraneo diventi noi, non individuabile. Rientrato il Bergamino si guarda allo specchio com’è sua abitudine. Gli sembra di non vedere più il suo viso riflesso a portata di mano, bensì quello di un pazzo. L’ossimoro intelligente stupido gli ritorna in mente. Il modo di agire di Ludovico Sforza detto il Moro sembra una sfida. Immagina di incontrarlo in una giostra. Entrambi immobili in arcione, chiusi nelle rispettive armature da torneo, si guatano attraverso la stretta fenditura dell’elmo. Il guardastanca, la piastra d’acciaio di rinforzo applicata sul lato sinistro della corazza toracica, splende al sole e quasi acceca. Si staccherà al primo urto di lancia avversaria. Copre a garanzia di una maggior sicurezza, segnalando, una volta sbalzata, se colpita in modo corretto. Hanno le rispettive lance già messe in resta, un ferro sulla destra della corazza, provvisto di coda uncinata che protraendosi dietro all’ascella, blocca il calcio della lancia. Tutti e due indossano un’armatura di tipo Stechzeug a piastre, la più massiccia mai realizzata, che garantisce l’incolumità del portatore sigillato nell’acciaio. Solamente le gambe rimangono scoperte, in quanto già protette dalla gualdrappa corazzata del destriero. La fantasia del Bergamino già galoppa mentre è ancora fermo in arcione. Mette in pratica tutto ciò che Cecilia gli ha appena raccontato. Sente di avere assimilato a sufficienza il Moro, ora si sente uguale a lui e può decidere di partire come un conte stupido intelligente, lasciando al duca il primo dei tre punti richiesti. Si incrociano a folle velocità, lascia che lo colpisca nella guardastanca che, provvista di apposita molla, vola a terra. Di proposito, evita di fare altrettanto e con la punta della sua lancia colpisce poco sopra la guardastanca del Moro, scivolandogli sulla spalla. Un punto al duca. Durante lo scambio, ricontrolla una zona debole, l’ascella, che si scopre quel tanto che basta per affondarvi la punta ottusa della lancia. Nell’incavo ascellare la difesa è soltanto la cotta di maglia ad anelli di ferro che non si lacera, ma si piega sulla punta dell’asta quel poco per traumatizzare. Nella seconda tornata, il Moro fa volare la seconda guardastanca del Bergamino ma vola pure lui. Con un grido lacerante piomba a terra e vi rimane immobile. Svenuto per l’acuto dolore provato nell’impatto, riceve immediato soccorso. Il medico Girolamo Visconti non troverà ferite, solo una enorme bolla bluastra, un ematoma, che richiederà lunghe cure per riassorbirsi e guarire senza complicazioni. Cecilia entrata alla fine del sogno ad occhi aperti, trova il marito saltellante come se ballasse una mazza rocca vivace, accompagnando la danza con queste strane parole: “Ho vinto, ho vinto, grazie all’ossimoro, ho rotto gli ossi al moro!” Cecilia, presa da un panico silenzioso, quasi vedesse, in quell’epoca, Guernica di Picasso, rimane per un po’ in silenzio, prima di chiedere spiegazioni a suo marito. “E’ merito tuo se mi trovi così allegro, mi sono assimilato a Lodovico Sforza e ho agito, come lui, da intelligente stupido.” Cecilia, donna colta, intelligente che oltre al latino parla anche un po’ di greco, sa che la parola “ossimoro” deriva dal greco ὀξύμωρον, composto da ὀξύς, «acuto, intelligente» e μωρός, «ottuso, stupido». Lo spiega con calma a suo marito, in ansia anche se riguarda un’immaginazione fatta da un personaggio che se non ci fosse bisognerebbe inventarlo. E’ un attore così tragico che a volte non può non strappare una risata. “Divertentissimo l’accompagnamento vocale che facevi poc’anzi nel tuo ballo solitario. Ringraziavi l’ossimoro e subito dopo lo scindevi in ossi e moro; Moro come è chiamato il Duca Lodovico Sforza. Non mi diverto invece quando dici di agire da intelligente stupido, come fa lui. Vuoi spiegarmi a che cosa pensavi di tanto allegro per metterti a danzare e a cantare ripetutamente quel ritornello?” “Cara Cecilia, è molto semplice. Sono anni che lo servo e da lui ho imparato a dire e a non dire la stessa cosa, a farla e non farla. Ma prima l’immagino, mi sento di più a mio agio dopo, col dire non dire o col fare non fare. La verità, secondo me, non esiste, c’è solo una dimensione narrativa della cosiddetta verità. Persino la scrittura è invenzione, e la differenza, tra me e lui, è che il Moro non se ne accorge, ma io sì. Nella mia giostra immaginaria, ho due possibilità; far finta di perdere e mettere a segno il colpo vincente, una vincita perdente sincrona, non ti pare?.”“Capisco, ma in una reale tenzone, anche se per te non esiste, finiresti malissimo e nel peggiore dei modi, saliresti sul patibolo, per attentato alla vita del tuo signore.” “Direi proprio di no! Nel primo assalto mi lascio colpire nel mio bersaglio ed evito il suo scivolandogli sulla spalla, appena al di sopra della guardastanca, tutto regolare, quindi. Nel secondo gli lascio nuovamente fare centro ma, nello stesso tempo, dirigo la punta della mia asta sul bordo della sua guardastanca, la sposto e penetro nel cavo ascellare. Nessuno può pensare che l’abbia fatto di proposito! E’ stata una disgrazia.” “Comunque tutta l’azione è solo immaginata, non sappiamo come sarebbe nella realtà!” “E’ vero, perdo e vinco in contemporanea, e questo ossimoro, come tu lo chiami, è per me un sedativo, anche se immaginifico. Se risolvo la lotta dei contrari, allento la tensione, lo stesso mi accade quando scrivo, non dimenticare che sono sempre un narratore, un inventore di racconti.” “In altre parole possiedi un coraggio creativo, la cultura per te è un qualcosa di fantastico, reinventi tutto attraverso un linguaggio figurato, ricorri alla metafora, per te le spighe ondeggiano come se fossero un mare” “Quando mi parli così, mi sento un leone!”